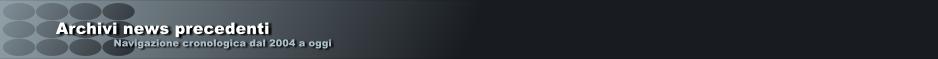L'occhio umano è sensibile solamente alle onde
elettromagnetiche con lunghezze d'onda comprese tra 400 ed i 700 nnmt
(il cosiddetto "spettro visibile").
Ovviamente, questo intervallo di lunghezze d'onda
costituisce una porzione assai piccola dell'intero spettro delle onde
elettromagnetiche. Per confronto, possiamo vedere che l'intervallo di
sensibilità alla luce in molti animali è notevolmente diverso dal
nostro. Per esempio, gli occhi delle api sono sensibili alle lunghezze
d'onda nell'intervallo da 300 a 650 nm (anche una porzione
dell'ultravioletto vicino) e sono quindi in grado di vedere
"colori" a noi sconosciuti. E' di fondamentale importanza premettere che le
sostanze o gli oggetti del mondo reale non sono però colorati di per se
stessi. I corpi che ci circondano hanno la facoltà di emettere,
riflettere o di trasmettere onde elettromagnetiche di diversa lunghezza
d'onda e di diversa intensità, tali da stimolare il nostro sistema
sensoriale e provocare la visione dei colori.
Adottiamo qui la definizione di colore formulata
dal Comitato sulla Colorimetria della Optical Society of America:
"Il colore consiste nelle caratteristiche della luce diverse dalle
inomogeneità spaziali e temporali; la luce essendo quell'aspetto
dell'energia raggiante di cui l'osservatore umano ha conoscenza
attraverso la sensazione visiva che nasce dalla stimolazione della
retina dell'occhio". Per caratteristiche della luce si intendono tre
parametri, che saranno specificati in dettaglio nel seguito, il primo
dei quali è connesso alla capacità della luce di provocare la
sensazione di luminosità; il secondo e il terzo esprimono invece la
sensazione cromatica percepita dal sistema visivo ed espressa dalla
lunghezza d'onda dominante e dalla purezza del colore. L'insieme dei tre parametri costituisce ciò che
chiamiamo "attributi del colore"
Si dice che un oggetto ha un determinato colore
quando, illuminato da una luce considerata bianca (ad esempio la luce
del sole) ed osservato in determinate condizioni standard, provoca
nell'Osservatore una "percezione cromatica". Qualsiasi luce
che non contenga tutte le radiazioni monocromatiche nella proporzione
della luce solare è percepita come colorata.
|
L'occhio umano, illuminato da luce monocromatica
di varia lunghezza d'onda, percepisce i seguenti colori:
da 400 a 430 nm: zona del violetto;
da 430 a 490 nm: zona del blu
nelle sue seguenti tonalità intermedie:
da 430 a 465 nm : indaco
da 466 a 482 nm : blu
da 483 a 490 nm : blu verdastro
da 491 a 560 nm: zona del verde
nelle sue seguenti tonalità intermedie:
da 490 a 498 nm : verde bluastro
da 499 a 530 nm : verde
da 531 a 560 nm : verde giallastro
da 561 a 580 nm: zona del giallo
nelle sue seguenti tonalità intermedie:
da 561 a 570 nm : giallo-verde
da 571 a 575 nm : giallo citrino
da 576 a 580 nm : giallo
da 581 a 620 nm: zona
dell'arancione nelle sue seguenti tonalità intermedie :
da 581 a 586 nm: arancione
giallastro
da 587 a 596 nm : arancione
da 597 a 620 nm : arancione
rossastro
da 620 a 700 nm : zona del rosso
nelle sue tonalità intermedie:
da 621 a 680 nm : rosso
da 681 a 700 nm : rosso profondo
|
A questo punto è lecito chiedersi come sia
possibile stabilire, in modo sperimentale, che la luce solare
effettivamente contenga tutte le lunghezze d'onda che provocano la
sensazione cromatica. La risposta è stata data tre secoli fa da Newton
con le sue fondamentali esperienze sul fenomeno della cosiddetta
"dispersione". Newton scoprì che, quando un raggio di luce
solare entra in un prisma di vetro, le componenti cromatiche associate
alle lunghezze d'onda subiscono una rifrazione che è diversa per
ciascuna di esse. Possiamo notare, infatti, che ogni colore subisce,
all'interno del prisma, una deviazione dalla propria direzione di marcia
che risulta essere tanto maggiore quanto più piccola è la lunghezza
d'onda ad essa associata. Quindi il rosso, che ha la lunghezza d'onda
maggiore, è deviato molto meno del violetto.
L'effetto finale di questo fenomeno di dispersione
nelle sue componenti cromatiche fondamentali può essere direttamente
osservato su di uno schermo posto alle "spalle" del prisma: la
luce sarà dispersa, colore per colore, su una certa zona ed è molto
interessante vedere come sia possibile ricombinare i colori ottenuti a
seguito della dispersione, per tornare alla condizione iniziale di luce
bianca. Per ottenere questo effetto basterà porre in
prossimità del piano di formazione dello spettro un secondo prisma
uguale al primo, ma capovolto. Esso ricomporrà i colori restituendo il
fascio iniziale di luce bianca. Sebbene i colori dispersi dal prisma
siano virtualmente infiniti - in quanto possiamo pensare di suddividere
l'intervallo di lunghezze d'onda tra 400 e 700 nm in intervalli piccoli
a piacere - la sensazione visiva per l'occhio può essere ridotta a 6
famiglie di colori principali: violetto, azzurro, verde, giallo,
arancione e rosso (detti anche "colori puri" o
"spettrali").
L'utilità di queste informazioni
è sopratutto inerente alla querelle sugli "almost true
colors", concetto legato all'esplorazione spaziale e ai frames che
le sonde spaziali ci inviano da molti anni. In particolar modo la
diatriba è concentrata su Marte e i suoi colori: la NASA e, in modo
minore, l'ESA ci presentano il pianeta perennemente tinto di rosso.
Eppure ci sono sufficienti e validi motivi per ritenere che le cose non
stiano così. Con queste semplici nozioni
tecniche sulla natura dei colori e sulla propietà che gli oggetti hanno
di caratterizzarsi attraverso le onde elettromagnetiche, nonchè tenendo
conto della percezione visiva dell'occhio umano, possiamo farci un'idea
giò precisa su cosa significa vedere "a colori" e sul
"cosa vediamo attraverso i mezzi impiegati per farci pervenire una
determinata informazione".